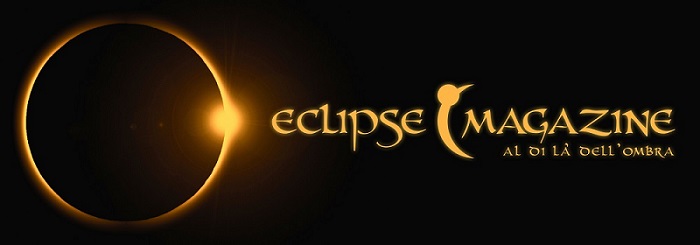- Al di là dell'ombra
Un medico con la passione per la letteratura: Anton Cechov e la sua epoca
Da musa di Besson a regista impegnata: i mille volti di Rie Rasmussen
Luglio 20, 2009Cavour 220. Il lusso sbarca nel centro di Roma
Luglio 20, 2009 L’Ottocento è stata un secolo di grande fervore culturale e di un ricco proliferare di personaggi e autori di interesse internazionale, ma è stato anche un’epoca di gravissime perdite, soprattutto per la letteratura russa di fine secolo.
L’Ottocento è stata un secolo di grande fervore culturale e di un ricco proliferare di personaggi e autori di interesse internazionale, ma è stato anche un’epoca di gravissime perdite, soprattutto per la letteratura russa di fine secolo.
A poca distanza l’uno dall’altro scompaiono Turgenev, Dostoevskij, Ostrovskij e Saltykov-Scedrin. Rimane attivo soltanto Tolstoj, anche se l’epoca dei suoi grandi romanzi può dirsi conclusa. In quegli stessi anni, fanno ingresso sulla scena culturale moscovita, dei piccoli brani che raccontano semplici storie, storie di tutti i giorni, prive di grosse pretese che nascondono un autore timido e modesto. È un medico, che scrive più per diletto che per vocazione, il suo nome è Anton Cechov. Nato in una famiglia non benestante, Cechov vive un’infanzia durissima, tra la violenza e la collera del padre e una religione forzata. I frequenti spostamenti, l’atmosfera provinciale di Taganrog, cittadina sporca, pigra e noiosa angosciano l’anima del giovane Cechov che grazie ad una borsa di studio ottenuta al ginnasio, riesce a trasferirsi a Mosca dove si iscrive, e si laurea, alla facoltà di medicina. Terzo dei sei figli, Anton Cechov cerca, con tutte le sue forze, di alleviare l’assai critica situazione economica della sua famiglia scrivendo dei racconti per le riviste umoristiche moscovite. I suoi racconti raggiungono presto la simpatia del pubblico e da nove, scritti nel 1880, si arriva ai tredici del 1881, per raggiungere i 119 del 1883. Ormai la notorietà di Cechov ha raggiunto gli onori della cronaca, la professione di medico, è esercitata solo saltuariamente, tra un racconto e un corto. Thomas Mann, scrittore tedesco, dirà di lui – può stare alla pari con quanto vi è di più forte e di più alto nella letteratura europea -. La copiosa produzione novellistica di Cechov è ininterrotta ed estremamente unitaria, il suo desiderio non è quello di salvare l’umanità o lanciare messaggi, ma aiutare la gente a migliorare, mostrandola così com’è fatta, come vive, e non come dovrebbe essere o vivere. La drammaticità esistenziale si dipana in tutti i racconti, rimanendo, però, più camuffata nelle novelle composte negli anni universitari, dove spicca soprattutto l’aspetto comico e grottesco. La forma e il successo arrivano con i brani delle due raccolte “Racconti variopinti” e “ Nel crepuscolo”. Poveri d’azione e quasi privi d’intreccio, i racconti ritraggono la piccola borghesia russa fatta di uomini frustrati, illusi, che si autoingannano e sperano, senza agire, in un mondo migliore. Ben presto Cechov sente una forte attrazione per il teatro, comincia così a cimentarsi in pièce per la scena, tenendo come base la struttura dei suoi racconti. L’intreccio è complicato, ma non banale, tutti gli atti si svolgono lentamente in una sorta di lungo e inesorabile scorrere del tempo dove si ha l’impressione che nulla cambi, ma che qualcosa involontariamente si stia trasformando. Tra il 1884 e il 1891 Cechov scrisse per il teatro otto atti unici, lasciando in alcuni, ampio spazio alla dimensione narrativa e al monologo. Ma i grandi capolavori dello scrittore russo sono: “Il Gabbiano” (1895), “ Zio Vanja” (1899) versione rifatta del “Lesji”, “Le tre sorelle” (1901), e “Il giardino dei ciliegi” (1904). In queste opere emerge lo stile compositivo cechoviano: l’attitudine alla rassegnazione di fronte all’ineluttabile trascorrere del tempo, l’attenzione quasi morbosa per il dettaglio psicologico, la necessaria ricostruzione di atmosfere più che di vicende, l’assoluta mancanza di un protagonista. I personaggi, completamente allivellati sul piano narrativo, sono incapaci di parlarsi, di ribellarsi al destino, sono immersi in una sorta di sonnambulismo, in una perenne attesa di qualcosa che deve arrivare o succedere ma che non avviene e non è dato conoscere. Una sorta di parallelo con le più famose opere di Beckett, con gli stessi silenzi e gli stessi vuoti di comprensione. Il nome di Cechov non è legato a nessuna scuola, corrente o etichetta, ma sicuramente possiamo inserirlo in quel filone che determinerà il teatro realista russo, ma ancora di più possiamo definirlo precursore, della drammaturgia moderna. I suoi racconti così come il suo teatro sono un atto di accusa contro la società del suo tempo troppo pigra e troppo vittima di sé stessa. Lo stile semplice e sobrio, modellato sul tragico quotidiano lascia intravedere uno scrittore introverso, schivo, ma capace di essere ironico, come quando in punto di morte, nel 1904, a soli 44 anni, invece dell’ossigeno reclama lo champagne, mormorando in tedesco “Ich sterbe” (io muoio).
di Maria Teresa Pasceri