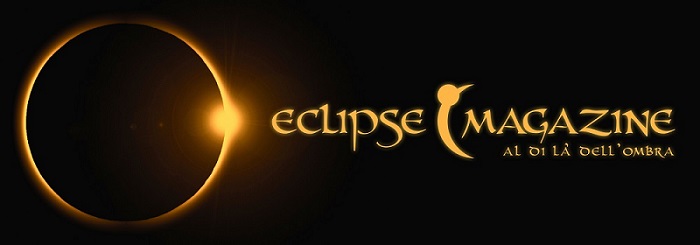- Al di là dell'ombra
Zone d’Ombra: falsi abusi e false confessioni
Il Racconto dei Racconti
Maggio 15, 2015B.B. King: addio all’ultimo Re del blues
Maggio 15, 2015Gli scherzi della memoria
C’è un uomo, negli Stati Uniti, di nome Martin Tankleff, che ha scontato diciassette anni di carcere in un istituto penitenziario di massima sicurezza, Dannemora, a New York, per un crimine mai commesso. Fin qui la storia sembra ripetersi secondo un copione maledetto. Errori legali, abbagli giudiziari, sviste fatali che fanno di un innocente un’incauta vittima del sistema. Solo che, in questo caso, a incastrare Martin è una sua stessa, sorprendente, confessione. In cui si autoaccusa dell’omicidio di entrambi i genitori, ritrovati accoltellati la mattina del 7 settembre 1988, nel loro appartamento a Long Island. Martin non ha ancora diciotto anni, e quello è il primo giorno di scuola. A rinvenire i corpi dei due è proprio il figlio, il quale non esita a chiamare i soccorsi. Ma le sue mani sono intrise di sangue. E ostenta una freddezza inspiegabile. Tanto basta per interrogarlo. Dopo circa cinque ore di estenuante confronto, gli viene riferito che suo padre, in fin di vita in ospedale, lo ha indicato come responsabile. Ma si tratta di una bugia. Martin si convince di essere l’assassino, e firma una confessione. Suo padre muore di lì a poco, portandosi dietro la verità. Oggi Martin, in seguito a una lunga e ingiusta prigionia, è un uomo libero ed è stato risarcito dallo stato per 3,3 milioni di dollari.
Ma perché, se innocente, firmò quella confessione? Si può essere persuasi, sebbene per pochi, brevi istanti, di aver commesso un crimine mai avvenuto nella realtà?
La risposta si trova in una serie di esperimenti che la psicologa forense americana Elizabeth Loftus ha compiuto negli anni Settanta, inducendo un gruppo di persone a costruire dei falsi ricordi sulla base di un’informazione sbagliata. La memoria, quindi, non registra fedelmente gli avvenimenti passati, ma li reinterpreta, arrivando persino, in alcuni casi, a stravolgerli. E ciò è tanto più vero quanto più qualcuno, di cui ci fidiamo e a cui attribuiamo autorevolezza, ci convince che le cose stiano proprio così. Deve essere andata in questo modo per Martin, il quale, nella centrale di polizia, fu portato a credere, tramite una menzogna, che suo padre e il detective, persone certamente per lui influenti, lo ritenessero colpevole.
La Loftus, dimostrò anche come, non di rado, alcune false memorie avessero preso forma nel corso di una psicoterapia. Molte di queste riguardavano abusi subiti nell’infanzia. Già Freud (1897) aveva messo in guardia sulla possibilità che i pazienti non sempre raccontassero episodi realmente accaduti, ma che piuttosto si affidassero alla propria fervida immaginazione. Una teoria, quest’ultima, a lungo discussa, per aver contribuito, suo malgrado, a tenere nell’ombra abusi e abusatori (quelli veri, che pure esistono).
Furono soprattutto le riflessioni di una psicoanalista svizzera, Alice Miller (1985), a restituire credibilità ai racconti dei bambini, in particolare laddove questi gettavano luce su traumi e violenze familiari. In molti confessarono pubblicamente di essere stati vittime di molestie, durante l’infanzia. Ma, anche in questa circostanza, non mancarono illustri ritrattazioni. Celebre il caso di Meredith Maran, giornalista statunitense, che, nel 2010, scrisse un libro, dal titolo emblematico “My lie. A true story of false memory“. Facendo una personale ammenda, dichiarò falso quanto precedentemente dichiarato sulle presunte attenzioni sessuali del padre nei suoi confronti. Si sbagliava. Ecco tutto. L’errore le era costato la brusca interruzione dei rapporti con la famiglia, nonché la rottura di un matrimonio. D’altro canto la verità ha molte facce. E spesso si somigliano.
di Michela Carrara