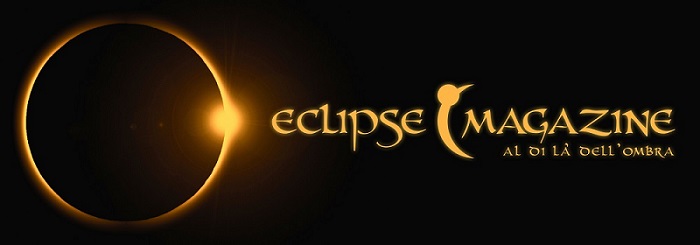- Al di là dell'ombra
Zampilli di storia
Paranormal Activity: in arrivo il quarto capitolo
Gennaio 18, 2012Eclissi di note: “While my guitar gently weeps” – The Beatles
Gennaio 19, 2012 Dalla staticità del bronzo e del marmo il movimento dell’acqua.
Dalla staticità del bronzo e del marmo il movimento dell’acqua.
Dalla fontana delle Tartarughe si aprono i cancelli del ghetto
È una tra le fontane più belle di Roma, in cui l’armonia della forma raggiunge la perfezione, e a goderne è lo sguardo e l’animo. Da più di quattrocento anni si sente l’eco del fluire dell’acqua in piazza Mattei, e la leggenda prende corpo. Si dice che il duca Antonio Mattei fosse innamorato di una giovane damigella molto ricca di famiglia e che volesse convolare a nozze con lei. Le male lingue di cui ogni città è ben fornita riportarono al padre della giovane la notizia che il Duca volesse in realtà sposarsi per mettere mano al patrimonio familiare, visto che la stirpe Mattei risultava essere piena di debiti e con le casse ormai vuote. Il Duca sentendosi rifiutare la fanciulla volle indagare sul perché di quella inaspettata decisione, e giunto a conoscenza di ciò che si vociferava sulla sua casata, decise di invitare a cena la famiglia della giovane. Pregò il padre di lei di intrattenersi fino a tarda notte, perché a sua insaputa aveva dato ordine di erigere la splendida fontana nel mezzo della piazzetta. Poco prima che fosse l’alba invitò il suo ospite ad affacciarsi alla finestra dalla quale la fontana era ben visibile facendogli mirare cosa era capace di fare in una notte uno squattrinato Mattei… e il matrimonio andò a buon fine. A memoria dell’accaduto il Duca fece murare la finestra perché nessuno da quel giorno in poi potesse godere di quella visione, ed ancora oggi è in quello stesso stato. Ma la leggenda non è storia. Nel 1585 fu eretta nell’attuale centro di piazza Mattei la “Fontana delle Tartarughe”su progetto di Giacomo della Porta. Fa parte di un programma di ampliamento idrico di Roma portato avanti dai papi Gregorio XIII (1572-1585) e Sisto V (1585-1590), e come sempre nel corso dei secoli ormai andati l’utile si è fuso con il bello: in una vasca circolare quattro grosse conchiglie di marmo sono la base sulla quale sono adagiati quattro delfini. Su di essi poggiano il loro piede altrettanti efebi di bronzo che spingono con un braccio le tartarughe ad abbeverarsi nel catino superiore. La sensazione è il movimento perché le figure bronzee, realizzate da Taddeo Landini, aiutano le tartarughe, aggiunte dal Bernini nel 1658 dopo un restauro della fontana, col braccio opposto alla gamba sulla quale poggiano sui delfini, mentre le tartarughe stesse sono in procinto di arrivare alla meta, ma ancora arrancano. Nella piazza si affacciano alcune costruzioni cinquecentesche, tra le quali palazzo Costaguti, che ha all’interno degli affreschi e dipinti attribuiti al Lanfranco, al Domenichino e al Guercino, ma purtroppo non aperti al pubblico. Dall’altra parte della piazza c’è il palazzo Mattei, famiglia di antica nobiltà la quale aveva tra l’altro il compito di chiudere una delle porte del ghetto ebraico, organizzato in seguito alla bolla papale di Paolo IV (1555-1559) intitolata Cum nimis absurdum (“quando il troppo è inopportuno”). In quel periodo storico la comunità ebraica di Roma contava tremila persone che vennero costrette a risiedere all’interno del ghetto, l’allora “recinto degli Hebrei”, la cui superficie totale comprendeva all’incirca tre ettari. Da quel momento in poi gli abitanti del ghetto per più di tre secoli furono costretti a rientrare al calar del sole all’interno di questo perimetro, perché dal tramonto all’alba i tre accessi venivano serrati con delle grosse porte delle quali ai giorni nostri sono visibili solo i cardini. La giustizia papalina non aveva nessun riguardo per chi si attardava e rimaneva chiuso fuori.
La costruzione della “Fontana delle Tartarughe”, in questo preciso contesto storico, ebbe anche la funzione di costituire un nuovo punto di approvvigionamento d’acqua per il ghetto, seppur edificata appena al di fuori del suo perimetro.
di Svevo Ruggeri